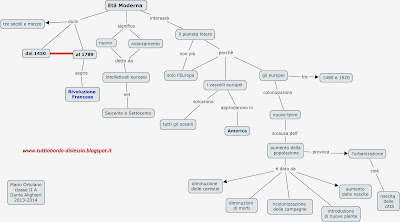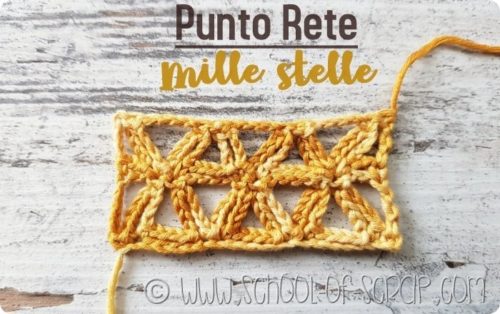![]()
![]() L’operatore accanto al morente
L’operatore accanto al morente
Nella fase della fine vita il malato è immerso in quella dimensione che Campione ha definito metaforicamente “terra di nessuno” (F.Campione, 1996), una situazione cioè in cui si sente che la vita ci abbandona ma ci si sente ancora vivi; una terra che non produce altra vita ma che non è ancora deserto. In questa condizione noi possiamo, con una gamma infinita di modalità, valorizzare la vita che rimane, la terra, oppure valorizzare la morte che avanza, il deserto.
Il morente ha dunque bisogno di un contesto intorno che se ne prenda cura, che gli comunichi e trasmetta la vita, allontanando le maggiori angosce di morte che prevedono vissuti di derealizzazione, depersonalizzazione e destrutturazione, e dunque relativi alla perdita del legame e all’abbandono nella solitudine. Questa condizione porta il morente a forme estreme di regressione che gli consentono la gestione di tali angosce; ciò fa emergere bisogni psicologici di vicinanza affettiva, ascolto, contatto, che devono essere riconosciuti ed accolti da parte di coloro che professionalmente se prendono cura.
Chiunque operi in un contesto che si occupa della cura dei morenti sperimenta costantemente la difficoltà ed il peso della relazione con questa realtà. Ciò che rende faticosa questa esperienza di assistenza è l’inevitabile incontro/scontro con il fenomeno del rimosso della morte che viene invece “sfacciatamente” e incessantemente riproposto dal morente stesso. L’operatore si trova dunque quotidianamente a contatto con i temi dell’impotenza, del limite, della perdita, della morte che muovono in lui emozioni intensissime e rimettono in gioco tutte le esperienze personali di separazione, abbandono ed impotenza. Il lavoro dell’operatore accanto alla persona morente, pertanto, non è caratterizzato soltanto da sentimenti di amore, condivisione, comprensione, ma comporta normalmente vissuti di angoscia, inutilità, frustrazione e rabbia. Tali esperienze, se non ben conosciute e veicolate da parte dell’operatore, possono avere effetti dirompenti di frustrazione ed aggressività nelle dinamiche relazionali con chi ha bisogno di cura.
Lo stato d’ansia, di disagio e di inutilità che può derivare dal contatto con la morte ed il morire può portare a varie modalità di auto-protezione psicologica da parte dell’operatore, nel tentativo di sfuggire al rischio di identificazione con il malato e la sua sofferenza. Tali modalità si traducono in atteggiamenti di oggettivazione del malato, di eccessivo tecnicismo o di accanimento terapeutico, che permettono di tenere le dovute distanze emotive dal malato e dalla sua sofferenza, rifiutando la relazione con lui.
La situazione opposta è quella che si esplicita in un coinvolgimento emotivo incondizionato con il morente e la sua condizione. Qui non ci sono barriere o limiti di tempo, si attua una vera e propria identificazione, ci si fa “invadere” dalle emozioni di quest’ultimo, rischiando di con-fondersi con lui.
Come dice L.Sandrin: “il cammino psicologico del malato morente è in gran parte condizionato dal tipo di relazioni in cui il malato stesso è inserito e a sua volta condiziona queste relazioni, in un circolo vizioso senza fine”. Il giusto atteggiamento da parte dell’operatore è dunque caratterizzato da un attento ascolto dei bisogni sempre più regressivi del morente , ma anche da una capacità di rimanere aderente agli elementi di realtà che lo aiutino nella gestione dell’esperienza.
Ne consegue che, per realizzare un’adeguata assistenza al malato morente nell’accoglimento dei suoi bisogni e coinvolgersi con la sua sofferenza pur mantenendo la giusta distanza emotiva, sarebbe auspicabile per l’operatore, compiere un percorso personale di conoscenza di sé e delle proprie motivazioni; acquisire una maggiore consapevolezza ed accettazione dei propri limiti, della propria non-onnipotenza, della morte, sia come operatore sanitario che come persona. Per raggiungere tutto questo, mi pare di poter sostenere il valore fondamentale e irrinunciabile di almeno due aspetti: la formazione individuale e il lavoro di gruppo.
La prima non si realizza solo con l’acquisizione di contenuti e di abilità tecniche, ma con un processo di elaborazione e di consapevolezza di sè che permette di acquisire anche nuove modalità di relazione e di comportamento. Il secondo aspetto mette in evidenza l’importanza del lavoro di gruppo il quale offre da un lato la possibilità di una riflessione collettiva per condividere emozioni e dubbi, prendere decisioni insieme, dall’altro permette di costruire un percorso che vada oltre l’esperienza della perdita, aiutando gli operatori a condividere con gli altri e ad elaborare le emozioni legate al proprio lavoro.
Avvicinarsi al morente con serenità per rendergli più confortevoli e significativi gli ultimi giorni della sua vita è un atto di grande professionalità e umanità ed è anche un modo di riconciliarsi con la propria morte.
dott.ssa Anna Luisa Mariggiò
Psicologa psicoterapeuta
BIBLIOGRAFIA
Viafora C., Fondamenti di Bioetica, Ambrosiana Editrice, Milano, 1989
Sandrin L., Capire e aiutare il malato,Edizioni Camilliane,Torino, 1989
Campione F., Il deserto e la speranza, Armando Armando, Roma, 1990
Bonetti m., Ruffato M.T., Il dolore narrato Centro Scientifico Ed. Torino 2001